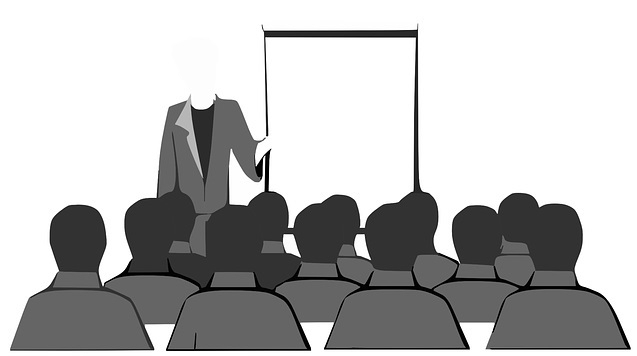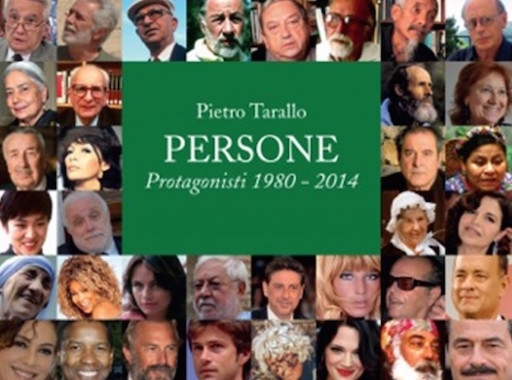La dea di Santiago Atitlan
La storia di Itzamnà e di Lyuna
Pop, No, Zip, Zotz, Tzec... Non si sta vagliando un'esclamazione da inserire in un fumetto, tipo Gulp o Sbam. Si tratta di scegliere il mese migliore per visitare il Guatemala, laddove gran parte della popolazione fa riferimento al calendario maya. I mesi di questo calendario sono 18, durano 20 giorni l'uno e hanno nomi brevi come Zip, ma anche come Zac o Pax (poiché il computo totale dei giorni arriva a 360, per omologare l'anno a 365 albe i maya aggiungevano 5 giorni di Uayeb, ritenuti portatori di dolori e sfortune).
Io andai nel mese di Kayab, primi giorni di dicembre, a stagione delle piogge conclusa. Era la fine degli anni ‘80 e se pensate che stia per proporvi un reportage datato, tenete presente che in Guatemala il tempo avanza alla velocità di un bradipo col freno a mano tirato: oggi, per quel che ne so, il Paese non ha avuto variazioni rilevanti rispetto al tempo del mio viaggio.
Antigua è una splendida cittadina, 30 chilometri a ovest della capitale Ciudad de Guatemala. Le strade acciottolate separano case basse color pastello, ombreggiate di tanto in tanto da monumentali chiese barocche, di stampo ispanico. Da un lato della Plaza Mayor presi uno scuolabus riciclato a mezzo di trasporto pubblico: aveva un muso prominente che includeva il motore e il giallo originario era sbiadito. Notai le gomme lisce come pelle di un bambino nero.
I passeggeri erano tutti locali, maya purosangue, vestiti alla loro maniera. Le donne portavano gonne lunghe fino alle caviglie, piene di strisce intersecate viola/azzurre/rosse. Il busto era coperto da huipil, blusa ipercolorata fatta di tre pannelli di stoffa di cotone su cui vengono ricamati fiori o animali. Le spalle erano avvolte dall'inseparabile tsute, scialle ciclamino/arancio/rosa, utilizzato per portare i bambini sulla schiena/per riparare il capo da sole e vento/per ornamento civettuolo.
I pantaloni degli uomini erano immacolati oppure rossi con righe bianche. Le giacchette erano abbellite da pipistrelli blu, biscioni nocciola e motivi geometrici. Cappelli a larghe tese, ispirati ai panama, proteggevano le teste.
Gli indigeni erano proprio corti, tra il metro e 60 e il metro e 70. I piedi che calzavano il 37 erano da considerarsi giganteschi. Avrei potuto avere un futuro da pivot in una squadra di basket della zona, anche se trovare abbigliamento della mia misura sarebbe stato difficile.
Il guidatore del bus si chiamava Huracàn: così lo salutavano quelli che montavano a bordo. Aveva una sorta di divisa da lavoro, camicia e calzoni verde marcio. La pelle si sarebbe mimetizzata su un parquet color cedro. Capelli nero notte, senza luna. Gli occhi marroni nuotavano in abbondante liquido lacrimale. Gli solcava la fronte una ruga orizzontale in cui si poteva incastrare una biro.
Viaggiammo sulla carrettera nazionale interamericana che si inerpicava tra montagne brulle. Il bus andava su in prima e implorava che ci fosse una marcia più bassa. Se la strada brevemente spianava, Huracàn si fermava a raccogliere gente in attesa. Salivano soprattutto donne che il guidatore, fingendo cortesia, smanazzava. Alcune reggevano gabbie con galline imprigionate, altre portavano grossi fagotti a cavallo della clavicola.
Al passo di Chimaltenango, paesone a 1800 metri in cui i maya costruivano scudi, ci fu una sosta di mezz'ora. Il motore era caldo quanto un caminetto all'inferno. Huracàn ai avvicinò a cinque cani randagi che parevano aspettarlo. Versò da un sacchetto pezzi di carne cruda che le bestiole trangugiarono: avevo letto che quello era un rito portafortuna per ingraziarsi gli spiriti del viaggio.
Dopo lo scollinamento la carrettera divise abetaie alpine di un verde brillante. Quindi scese d'altitudine e fu pressata dalla foresta pluviale verde chiaro. Passate due ore vidi la mia meta, il lago Atitlan, definito dall'esploratore tedesco Alexander von Humboldt “il lago più bello del mondo”.
Il guatemalteco Miguel Angel Asturias, Nobel per la letteratura nel 1967, avrebbe così descritto la mia visione: “fiume dalle gengive di sabbia, immensi denti di sasso e lingua liquida di specchio”. In effetti un immissario scorreva tra argini sabbiosi e si buttava in un bacino rispecchiante il sole, presidiato a nord da tre vulcani puntuti come canini.
Il bus terminò la corsa a Panajachel, sponda sud del lago, 1600 metri sul livello del mare. La Calle centrale era un susseguirsi di alberghi asimmetrici, di rumorosi bar, di negozi di artigianato, di agenzie di viaggio. Tuk tuk strombazzanti insidiavano i polpacci. I bianchi europei erano la maggioranza. Decisi di andare subito al molo e mi imbarcai su una lancia a motore coperta che, seguendo il perimetro dell'Atitlan, toccava tutti i paesini della costa. Scesi a Santiago.
Per la notte scelsi un minialbergo con tetto d'erba e bambù. La stanza aveva mobili di cipresso. In serata optai per un ristorante con terrazza sul lago. La padrona messicana mi propose uno stufato di iguana. Rifiutai visto che mi impressionano anche le rane fritte. Mangiai la cochinita pibil dello Yucatan, cosce di maiale marinate nel succo di arancia, cotte in foglie di banano e insaporite con spezie incendiarie.
Venne a sedersi al mio tavolo una faccia da Jesus Christ Superstar. Capelli biondi, grossi e lunghi fino alla base del collo. Accigliato. Occhi verdi. Due virgole di baffi. Età giusta per la crocefissione. Gli indovinai il pedigree prima che parlasse. E colsi nel vero perché sapevo che in quasi tutti i villaggi a bordolago fiorivano comunità hippy.
Grazie alla nomea di luogo intriso di magia il lago era diventato la residenza di cercatori di, chiamiamoli così, Ottimizzatori Mistici. E cioè Maestri che depurassero un karma tossico, che ricostruissero l'albero genealogico dell'anima, che scovassero il giusto spirito guida e lo convincessero a fare da hostess; che prescrivessero diete con erbe miracolose presenti solo nei paraggi; che fossero dei catalizzatori di energia elettromagnetica; che rinnovassero il contratto di lavoro all'Angelo Custode, che tagliandassero insieme i corpi eterico/astrale/fisico, che suggerissero una frase-mantra la cui ripetizione concedesse soddisfazione a un desiderio, che fornissero camicie e mutande antimalocchio.
Il mio commensale si chiamava Alvaro, era spagnolo e si era già fatto le comunità hippy di mezzo mondo: Goa in India, Pokhara in Nepal, Nimbin in Australia, Tulun in Messico, Valle della Luna in Sardegna. In quest'ultimo posto aveva imparato l'italiano. Lì a Santiago aveva trovato, come Carlos Castaneda, il suo sciamano mesoamericano, il suo don Juan con “una strada che avesse un cuore”.
La mattina passeggiai con Alvaro. La temperatura era di 25 gradi. Costeggiammo l'Atitlan verdeazzurro, fermandoci a guardare lavandaie che sciacquavano i panni nel lago. Una clinica della fertilità accoglieva signore infeconde da riconvertire a madri. Salimmo al mercato da un viottolo sassoso. Il mercato era un'overdose di colori: venditrici nei loro costumi policromi commerciavano, sotto ombrelloni variopinti, stuoie/abiti/borse/coperte in cui il rosso si associava al nero, il blu elettrico al giallo, il fuxia al bianco.
Ceste ospitavano fragoloni/ananas/cipolle/pomodori/fagioli/avocado/cocomeri e cherimoya al gusto di frullato tropicale. Ragazze portavano sulla testa bacinelle da cui occhieggiavano carote e ravanelli. Pittori esponevano tele a olio fiammeggianti. Intagliatori del legno smerciavano maschere orrifiche.
Arrivammo alla piazza, fiancheggiata da un portico, senza traffico, con turisti cosmopoliti. Fui attirato da bambini seduti su un lungo gradino, vestiti tutti da una tunichetta ocra che sembrava una tenuta scolastica. Avevano carnagione ruggine, capelli scuri e lisci ad eccezione di una bambina i cui capelli erano corti e gialli, simili a fiammiferi accesi. Pensai che la fanciulla fosse nata da una indigena e da uno straniero anche se ciò mi parve strano: nei villaggi sull'Atitlan ci si sposa esclusivamente tra compaesani e se qualcuno di un paese vicino si sposta a cercar moglie viene preso a mazzolate.
In piedi, di fronte ai bambini, gesticolava un uomo dal viso color rame, dai baffi grigi, infilato in un camicione nero, con una bandana arlecchina in testa. Parlava una lingua piena di x e di qu. Alvaro me lo indicò come Alom, il suo sciamano. Quando Alom si zittì, i bambini si alzarono e si misero in fila davanti alla marmocchia bionda: ognuno le fece una carezza sulla guancia.
Comprai due birre Gallo e mi sedetti con Alvaro sul gradino lasciato libero dai frugoletti. Il mio Jesus Christ, che aveva imparato anche la lingua locale kaqchiquel, mi disse che Alom aveva appena raccontato questa storia:
Santiago Atitlan era una volta governata dal giovane principe Itzamnà, il cui regno comprendeva anche altri paesi sulla riva del lago. La casa del principe non era certo un castello: era una casa bianca, costruita al di sopra di tutte le altre e agganciata alla prima collina come un balcone. Il principe possedeva un piccolo tesoro in pietre dure che suo nonno aveva conquistato in battaglie oltre le montagne.
Il principe era appassionato di barca a vela e ogni pomeriggio regatava sull'Atitlan. Il vento aveva con lui una tenera amicizia e cominciava a soffiare non appena la barca di Itzamnà si staccava dal molo. Quindi spirava dolce, in modo che il principe potesse solcare il lago con traiettorie curve o diritte.
Un giorno i due più brutti ceffi del paese entrarono nella dimora del principe che, essendo l'ora della siesta, dormiva. I loschi figuri imbavagliarono e legarono Itzamnà. Gli rubarono il tesoretto ficcandolo in un sacco, poi corsero al lungolago. Salirono sulla barca del principe e salparono per raggiungere un approdo opposto, dal quale fuggire.
Il vento, convinto che Itzamnà fosse uscito per la gita pomeridiana, sospinse dapprima l'imbarcazione. Quando s'accorse che la vela veniva malamente manovrata, capì che il nocchiero non era il suo giovane amico. Allora il vento si infuriò, colpì con raffiche violente la barca, capovolgendola. I ladri affogarono e il tesoro si inabissò.
Il vento non si placò dopo l'annegamento. Anzi prese a piroettare impazzito intorno al centro del lago. L'acqua ribolliva e si gonfiava in onde che andavano a schiantarsi sulle coste. Presto il vento si ampliò a uragano, con artigli di nube e versi da gufo incollerito.
Il principe, liberatosi, consultò lo sciamano. Se il tifone si fosse spostato sul regno lo avrebbe raso al suolo. Lo sciamano decretò che l'unica possibilità di salvezza era offrire al vento la compagnia di una ragazza del paese. Solo una donna poteva placare una rabbia sovrumana.
Principe e sciamano interpellarono le fanciulle non maritate ma tutte non volevano rinunciare ad un futuro matrimonio oppure dicevano che il vento le avrebbe alzate in aria e scagliate chissà dove. Anche le donne di una certa età non sposate si proclamarono indisponibili: non avrebbero sopportato il mormorio del paese sull'incapacità di trovare marito e sulla conseguente accettazione dell'unione col vento.
Intanto le folate veementi avevano formato anelli che si incolonnavano, quello a pelo d'acqua di diametro più stretto rispetto a quelli che si sovrapponevano. Man mano che gli anelli si depositavano sui sottostanti la circonferenza aumentava. In breve si compose un tornado, un imbuto d'aria ruotante. Soltanto in cima gli anelli si buttarono un po' in fuori, conferendo al turbine una testa di drago.
In paese abitava una ragazzina di nome Lyuna che provocava negli altri disprezzo oppure disagio oppure ilarità. Aveva la pelle abbrunata come tutti ma i suoi capelli erano incredibilmente gialli. Forse era figlia del peccato o forse no. Di certo risaltava come un girasole superstite in un campo bruciato.
Anche a Lyuna venne proposto l'incontro col vento e lei, tra malinconia e fierezza, acconsentì. La ragazzina saltò su una barca che venne attratta verso il centro del lago da gorghi concentrici. A due metri dalla tromba d'aria Lyuna si buttò verso il tornado e si avvinghiò all'anello più basso.
Lyuna afferrò quindi il cerchio superiore e vi si issò. Dopo si aggrappò al terzo anello e anche su quello salì. Con molta fatica e sempre sull'orlo di precipitare la ragazzina conquistò gli altri anelli, fino ad arrivare alla gola del drago. Lì si appese alla mascella del tornado e solo a forza di braccia si portò davanti alla bocca, che baciò.
Il ciclone crollò di colpo, come lo zampillo di una fontana cui venga chiuso l'erogatore dell'acqua. Lyuna si tuffò da molto in alto e per fortuna non si fece male. Tornò a riva a nuoto.
Il principe volle sposare la coraggiosa Lyuna che, dopo un anno, partorì una bambina somigliante a lei, bionda come il grano.
Alom aveva postillato che da allora ogni donna bionda dava alla luce una bambina dai capelli gialli, la quale era per Santiago la garanzia contro eventuali inasprimenti del vento.
Trascorsi il pomeriggio in un parco, a parlare con Alvaro. I rami che ci riparavano erano d'appoggio per parrocchetti loquaci e per tucani che duellavano a colpi di becco. Si era alzata una brezza che sarebbe stata deliziosa per un velista: il mio amico disse che il venticello si chiamava xolocal e che si ripresentava ogni giornodopo pranzo.
Il mattino successivo Alvaro mi portò in una tabaccheria e mi fece comprare una bottiglia di rum Venado e una stecca di sigarette Payaso. Mi condusse davanti a una casa di tufo rosa dove erano già arrivati lo sciamano Alom e la bambina bionda, che mi venne presentata come Ilma. C'erano anche gli altri bimbi, altri tre sciamani vestiti come Alom e donne che recitavano una nenia.
Solo Alom, Ilma ed io, che pagai 10 quetzal a una guardiana, entrammo nella casupola. Era quello l'alloggio del Maximòn, divinità che è un incrocio tra un dio maya, il conquistatore spagnolo Pedro de Alvarado e il Giuda dei Vangeli. Tanti indigeni gli recano offerte come le mie, tabacco e liquori. Poi gli chiedono favori, miracoli, benedizioni. Il mio Maximòm era una statuetta di legno alta un metro e mezzo, abbigliata con gilet a scacchi e con sciarpa arancione. Aveva un cappello di paglia e una bocca ghignante al cui angolo era appeso un sigaro. Era contornato, sulla parete alle spalle, da immagini cristiane, un Gesù, una Madonna con bambino, un Giovanni Battista, un San Pietro. Ai suoi piedi si erano aperte stupende orchidee Monya, bianche e carnose. Un centinaio di candele ardenti erano state incollate sul pavimento: Alvaro mi aveva anticipato che quelle gialle volevano propiziare un buon raccolto, quelle rosse chiedevano la soluzione di problemi sentimentali, quelle bianche erano a tutela della salute, quelle nere dovevano procurare una disgrazia a un avversario. Alom si inginocchiò e passò a Ilma una candela celeste, simbolo di devozione pura. La bimba accese lo stoppino da una delle tante fiammelle.
Fuori dalla casupola si formò una processione: in testa Alom e Ilma, tenuta per mano. Dietro gli altri sciamani con ostensori d'argento. Poi Alvaro ed io. Poi i bambini. Poi uomini e donne che intonarono un canto melodioso. Salimmo per il paese, tra due ali di casette celesti. In cima, Santiago Atitlan terminava contro prati che smeraldeggiavano fino al vulcano San Pedro, violaceo.
L'ultimo edificio era la chiesa di Santiago Apòstol, costruita da frati francescani nel 1580. Il campanile tozzo a calce viva era abbacinante. La facciata era protetta da un loggiato in legno. Sulla gradinata erano sedute ragazze con turbanti rossi che sapevo essere fatti con stoffa alta 7 centimentri e lunga 20 metri. Le giovani donne bruciavano resina di copale che mandava un vapore bluastro e odore limoncino d'incenso. La processione si sciolse dentro la chiesa, illuminata da grossi ceri disseminati senza criterio. Il pavimento era sepolto da petali. Dalle pareti dell'unica navata incombevano sculture quali un leone, un angelo, un uccello quetzal, un probabile san Giacomo.
Echeggiavano i suoni di un flauto dolce e di una marimba, xilofono dai tasti di palissandro. Indigeni maschi volteggiavano scalzi e nudi dalla cintola in su, in armonia con la musica. L'incenso impregnava anche l'interno dell'edificio sacro.
Alom e Ilma avanzarono mano nella mano sulla bisettrice della chiesa. Si fermarono davanti all'altare, sormontato da una pala coloniale. Qui Alom sollevò Ilma dalle ascelle, innalzandola sopra il proprio capo. La mostrò tutto intorno, come fosse una coppa, un cucciolo di tapiro, un libro di culto. Poi la mise in piedi sull'altare
Tutti si stesero sul pavimento, ventre a terra, mento a contatto dell'impiantito, mani giunte sopra la testa. Io mi adeguai. La marimba suonò più forte.
Quando mi rialzai insieme agli altri, Alom iniziò una litania che cullava l'anima.
Fu allora che capii, un po' tardivamente, che a Santiago Atitlan la Diversità era una Dea.
ALTRI ARTICOLI


N°29
aprile 2024
EDITORIALE
Emilio Bonavita
Pericle –Discorso agli Ateniesi 461 a.C “Qui ad Atene facciamo cosi. Qui il nostro governo favorisce i molti invece dei pochi: e per questo viene chiamato democrazia. Qui ad Atene... continua »